Sergio Atzeni / Passavamo sulla terra leggeri
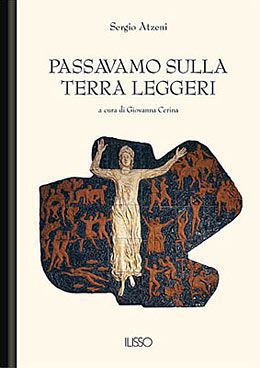 Ad Alessandro,
Ad Alessandro,
vero medico senza frontiere
per cui cuore e libri non sono mai stati stranieri.
Queste poche righe non sarebbero mai nate senza di lui
La voce è magia: ammalia, seduce, rivela e nasconde, misteriosa espressione dell’anima. La sua malia è innegabile. Più dirompente dell’immagine per il suo potere evocatore, per la possibilità di attivazione dell’immaginazione fantastica, quest’ultima limitata invece dai definiti contorni della figura, la voce come mezzo di espressione e narrazione evoca, crea, fa sognare. L’uomo ha raccontato di sé, del suo mondo, ha custodito la propria memoria tramite la parola detta -anche se, più correttamente, si dovrebbe dire cantata o, ancora meglio, ritmata- prima che scritta. Un complicato sistema mnemonico ha tutelato per secoli, se non per millenni, la memoria identitaria di molteplici civiltà tramite l’oralità. Raccontare era ricordare, ricordare e raccontare il passato, come ci insegnano le muse, era divino.
«Istintivamente mi sento un narratore orale», afferma con sincerità Sergio Atzeni, dandone testimonianza in quella che è la sua ultima opera, testamento della ricerca di una vita.
Passavamo sulla terra leggeri, pubblicato prima per Mondadori, ora in un’elegante edizione da Ilisso, è un’opera letteraria racconta da una voce, la voce di Antonio Setzu, ultimo custode del tempo. L’ultimo custode del tempo affida a un bambino di otto anni, che la riproporrà in forma scritta, la storia dei sardi. L’infante dimenticherà per trentaquattro anni, poi ricorderà tutto, parola per parola.
Antonio Setzu racconta di un tempo sospeso fra idillio e sogno, fra naturalità e bestialità, fra libertà e schiavitù.
In questa opera letteraria, dove è impossibile rintracciare un genere definito, dove poema epico si confonde con svariate tradizioni letterarie occidentali (pre-classiche e classiche) e non occidentali, fino a trovare fertile humus nelle tradizioni popolari, Sergio Atzeni si slancia nel tentativo, divino appunto, di ricostruire il passato, la Storia dei Sardi, dai suoi primi abitatori all’epoca -storicamente documentata-dei Giudicati.
Il sardo ha coscienza ( anche se ormai vaga e dai contorni indefiniti, schegge di antica identità) di essere stato oggetto di conquista prima da parte dei fenici, poi per mano dei romani, successivamente degli aragonesi, per concludere con la sottomissione ai Savoia, e la continuazione, sotto il loro scettro, del regno di Sardegna. Tuttavia è conscio, si aggrappa, ricorda con particolare attaccamento alla terra, che un nucleo originario, nascosto nel cuore dell’isola fra il Supramonte di Dorgali e Oliena, ha resistito, combattuto e difeso una terra, un popolo, un’identità.
E’ forse questo elemento, questa costante resistenziale sarda (come l’ha denominata Giovanni Lilliu) nella storia della popolazione che ha abitato l’isola (dai Nuraghi ai Giudicati), che costituisce il nucleo più profondo, vivo e pulsante della storia che Atzeni ha voluto raccontare. Raccontandola in una lingua che con l’intrecciarsi di diversi elementi (non riducibili ad un unico modello) ripete quella molteplicità di apporti che, per via della commistione di generi, caratterizza anche la tecnica narrativa. In questa sperimentazione, tensione dell’autore alla ricerca di un nuova forma espressiva per significare un mondo nuovo perché mai prima raccontato, si intrecciano anafore, avverbi di tempo e di luogo indefiniti, formule proprie dell’oralità insieme a un linguaggio che diventa spesso biblico, quasi mistico.
Tuttavia, se si vuole rintracciare la vera fonte di questa spasmodica ricerca, lo sguardo va diretto verso il tentativo di creare una lingua che abbia un legame indissolubile con il mondo della natura per raccontare un uomo diverso da quello che noi siamo e conosciamo. Un uomo che sentiva il battito della terra e non imponeva il suo, un uomo che -per l’appunto- passava leggero fra i fili d’erba.
Sergio Atzeni, ben conscio dell’illusoria verità materiale della storia -intesa come storiografia- ci lascia la sua personale storia dell’anima di un popolo.
Mentre nuotava nel mare della sua isola, vicino a San Pietro, quel mare che ha isolato e segnato i confini dei sardi, in una mattina del 6 settembre 1995, forse, sorrideva fra un’onda e l’altra. Aveva messo da pochi giorni l’ultimo punto a questa multiforme opera.
Prima dell’ultimo battito sorrise pensando che era così strana quella gioia intensa, quel camminare sulle nuvole e sentire l’anima farsi leggera e volare alta fino a Dio. Pensò di essere riuscito a raccontare, parola per parola, la sua storia.
Punto e a capo.
Matteo Demartis
